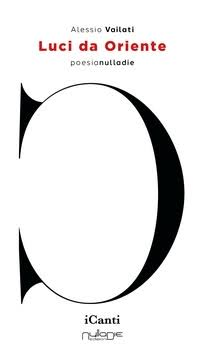La luce è di per sé pregna di pensiero e di epifania, «Luce intellettüal, piena d’amore», dice Dante. InLuci da Oriente Alessio Vailati le dà risalto già dall’esergo da Mario Luzi: «Si è qui, come si deve, inuna parte, / in un punto del tempo, in una stanza, / nella luce, nel divenire eterno». Nell’ossimoro del «divenire eterno» il punctum temporis del presente che fugge si discioglie in una luce più alta e limpida – quasi nella montaliana «eternità d’istante», o della luziana, appunto, «immensità dell’attimo». È il sentimento di qualcosa di impenetrabile, e tuttavia resta lo stridore tra il «divenire eterno» e l’essere situati «in un punto del tempo», in quel nonsenso fondamentale che, in quanto «traccia troppo labile», vanamente Vailati tenta di fermare in «una parola fra le tante / disperse, scomparse». Ed è la domanda sul senso («snidare nel grave / torpore dei tempi un segnale») a precludere ogni declinazione orfica dei nomi, non una domanda che contenga in sé il proprio fine, ma che dilazioni l’eco di sé, quasi una domanda vissuta, meditata, interrogata, possibilmente sostantiva, e non oltrepassata da parole definitorie: sfondo e orma quasi esclusiva della sua poetica – la così detta «idea del dire» – instillata nei versi. E quest’opera non fa eccezione. Luci da Oriente (Nulla Die, Enna 2022, Prefazione di S. Raffo) è un diario lirico scandito in quattro sezioni: «Una vita ordinaria», la sezione più folta, «Il labirinto», «Eternamente grande, infinitamente piccolo», e l’eponima «Luci da Oriente».
Il testo esordiale dà la misura della materia lirica di Vailati, la vita, la contingenza come sola necessità. E la dà al primissimo verso, senza prendere tempo. «Ci siamo cascati dentro / con il corpo e con il cuore, dentro / lo spazio finito, nel tempo». Ci siamo trovati ad essere senza aver scelto di farlo, l’esistenza ci viene imposta indipendentemente dal nostro volere. L’essere geworfen nel mondo, in quel labirinto che è motivo seminale e nucleo di polivalenza nella poetica di Vailati (e in merito rinvio a https://www.bibliomanie.it/?p=5977 ), ci caratterizza come identità monadiche senza garanzie esterne, costretti alla responsabilità di scelta che ricade sull’essere al mondo nell’abbandono e senza tutela né direzione («Tu e io siamo in un naufragio / [...] senza una rotta, immersi nella notte»), né direttive provvidenziali («Dicono che siamo soffio divino, / creatura perfetta nella imperfezione. / Ci credi?»). È la condizione dell’essere esposti, priva sia di significatività sia della facoltà di pensarsi come soggetti progettanti. Gettati nel mondo, gettati nel tempo, «essere alieni / persino al proprio agire», assegnati alla morte, o, che fa lo stesso, alla vita come mortalità intrascendibile.
D’altra parte, è assente in questi versi una qualche tensione oggettuale, l’oggettivarsi dell’occasione biografica o di realtà imbrigliate in una necessità stringente. Al di là di una oggettività naturalistica e di riferimenti atmosferici che, insieme alla congesta realtà metropolitana, costellano l’opera con spostamenti di senso («nebbia», «labirinto», ad esempio), sembra venir meno il tradizionale oggetto incarnazione di conflitti emotivi, o deputato a risospingere nell’ora il sostrato della memoria. Non c’è oggetto rivelatore: i margini della realtà, il sentimento di imprigionamento vengono espressamente dichiarati, asseriti, attestati e non assorbiti nell’oggetto, sicché l’inchiesta è tutta di pertinenza del «noi» in quanto esposti, soli e senza difese, a sostenere il peso del mondo in un dedalo esistenziale. Ad abitare il labirinto, che in Luci da Oriente non sempre obbedisce ai modelli vulgati e che vuol dire di volta in volta chiusura e limite, teatro di passaggi inestricabili, sfera nebulosa del passato, disorientarsi della conoscenza, realtà dispersa nei sogni dove le cause possono anche essere successive agli effetti, inconscio e la sua lingua che parla nella notte, cortocircuiti di senso. Nonché complessità dedalea della città allucinata e parossisticamente vociferante.
Questo passaggio ad ostacoli, la vita, è sostenuto da un dettato di coscienza tutt’uno con il paradigma colloquiale quale codice unificante: astenendosi dalla pretesa di indicare la soglia del trascendente, Vailati finisce per profilare l’inverso esatto del nichilismo e dell’estetica del vuoto. Perché scrivere il nichilismo – quando non assunto come punto di partenza ma come fine – suonerebbe come pretestuoso, una scappatoia, un rituale comunque sorpassato. O, come diceva Leibniz, «il nulla è più semplice e più facile che [postulare] qualche cosa». L’esistenza è costitutivamente disarmonica, ma non da giustificare il non volere, la trasgressione anche verbale, la tentazione nichilista della rinuncia e dell’oblio. Ci sono valori, se pure molto privati e molto precari, oltre la radicalizzazione nichilista e l’adeguamento alla tragicità mondana. E soprattutto, «siamo fatti per vivere». Detto altrimenti, e con più inerenza al testo, Vailati non oltraggia né sublima la vita e resta fedele alla propria memoria da proteggere, ad atmosfere, drammi, felicità esistite, all’evocazione di zone del passato («Te lo ricordi il mare»...), a un ricordare – o all’aver perso l’occasione per farlo – che interagisce con la trama del sé nell’esperienza presente e non con una immaginazione irridente scomposta. In Luci da Oriente la visione della vita come sottomissione al tempo e la decodifica memoriale (ovvero, in termini temporali, l’attenzione al tempo del soggetto, al proprio principio, al passato individuale, non la divinizzazione del passato irreversibile) non sono elaborazioni asincrone. E per certi aspetti divergono dall’evolversi della coscienza del protagonista della recente opera narrativa di Vailati, Ninfa alla selva (2024), storia di una rigenerazione a partire dalla necessità del caso, dalla casualità dell’incontro «fortuito e inevitabile», nella endiadi proustiana, che innesca l’imperativo della ricostruzione del senso sommerso dell’accaduto. L’artista ormai senza più ispirazione ritroverà il filo del suo processo creativo, insieme al contatto con il sé identitario, in seguito a uno scandaglio dei suoi giorni a ritroso nel tempo – torna l’idea del labirinto, e qui il filo è mentale, morale, come un comportamento, qualcosa che congiunga l’ora al già stato. Comprenderà, nel dipinto ritrovato, la trasmutazione della donna amata e perduta, «l’eternizzazione dell’ideale che in quel momento incarnava. Il tormento, l’estasi, il culmine di un orgasmo spinto al parossismo fino a dissolvere il tempo e annientare un’esistenza».
Per dichiarazione dell’autore, la vita non è mistero da trasfigurare, ma vincolo da condividere misurandosi con il cedimento immanentista, il naufragio, stigma ed emblema dell’esistenza individuale. Ora, «naufragio», così come «nebbia» che toglie l’orientamento, e quindi «smarrimento», sono allegorie significative, residui della Geworfenheit. Non siamo tuttavia sulla linea del naufragio ungarettiano, dal quale il poeta riemerge «alla luce coi suoi canti», Vailati insomma non sembra credere troppo nel valore eternante della poesia, o dell’arte, se ci rimettiamo all’explicit di Ninfa alla selva: «Mi domandai se gli artisti vengano davvero salvati dalla loro arte», arte che, tuttavia, in uno dei primi capitoli del romanzo, veniva definita come qualcosa «senza spazio e senza tempo, un’idea assoluta di Bellezza, slegata dai vincoli della finitezza e della caducità, proiettata costantemente verso l’Infinito e l’Eternità».
Naufragio è anche naufragio dell’opera, ma soprattutto della sovranità del soggetto su di sé. Finché non ci si imbatte nella figura predestinata a promuovere il processo di individuazione: un «tu» non ritornante alla prima persona singolare, con cui spartire il peso della temporalità inscrutabile (d’ora in avanti il linguaggio cessa di essere un monologo: «E confesso che è questa sintonia / di voci l’amore») e, senza le implicazioni delle filosofie dell’esistenza, il peso della problematicità della vita. Così come il confronto con la morte in vita, quel routinario inanellarsi di giorni vissuti inconsapevolmente. E con le ombre dei vivi morti, dei morti vivi, nel tempo ambiguo del qui ed ora e del qui per il tramite del non ora, vivente morente, che muore e rivive, in ogni frazione temporale della poesia, e di questa poesia.
Alterità non indefinita, non convenzione lirica dove si accampa un interlocutore generico e impersonale talora deificante, mai pretesto per un dialogo dell’autore con sé stesso, il «tu» di Luci da Oriente, nel suo temporalizzarsi, è diverso dal «tu» di Sulla via del labirinto (L’arcolaio 2010, Prefazione di A. Resuli). Identificato e divenuto rigorosamente allocutorio, è ora rivolto all’essere non più asintotico ma che ha un posto privilegiato nel suo tempo: alla sua donna. L’interlocutrice interferisce con le competenze del soggetto dell’enunciazione, così indotto all’estroversione, a portarsi fuori dall’alveo liturgico e anacoretico del cliché che vede l’io sfumare in immagine nebulosa di uno spazio di senso negato all’esistere, e assegnato all’esclusione e alla negatività storica. Il «tu» è qui presente e legato a contingenze biografiche e ad esigenze dialogiche. Ed è variabile all’interno del testo, essendo persona viva e amata che vanifica il detto per cui in due si può essere più soli che da soli – prova ne è l’immediato insediamento del «noi». In questo canzoniere le cose vanno altrimenti («insieme noi saremo forti», «una resistenza / ci nasce dentro, in mezzo a tanta giungla / e resistiamo...»), e i versi disegnano una tensione condivisa al fine di «salvarsi dall’inconsistenza». Perché la donna non è una seconda persona singolare trapiantata nei versi per esercitare vaghe facoltà soteriche (se il suo sorriso «non concede / un attimo di tregua dalla morte»; e in Piccolo canzoniere privato, del 2018: «non disperdere / i miei anni nella notte») o per promuovere la consapevolezza autoriale del soggetto della parola, o al contrario per fargli da schermo all’esclusione totale. E Vailati non esita ad autoschernirsi, citandosi nel suo romanzo. Il punto: «Recita una poesia, non ricordo chi ne sia l’autore, credo un poetucolo dei nostri giorni: Forse è così: si va per via di inerzia / a colmare per sempre una mancanza». In Luci da Oriente chi parla è il «tu», che usa la parola «inerzia», e non può esserci azione salvifica all’orizzonte della parola «inerzia».
I versi di Luci da Oriente sono inscritti in un contesto privato e discosto dai paragrafi della condivisione su larga scala, soprattutto nella prima parte, legata agli interrogativi e alle ansie della interlocutrice, senhal senza nome ma non recondito, non criptico. Da questo profilo possiamo considerare l’opera come seguito di Piccolo canzoniere privato, che più marcatamente raccoglie il dato biografico: qui dalle riflessioni di Dispersioni si passa a Luoghi, memorie e altri versi (incontro con la sua donna, i primi viaggi, la Scozia, la Norvegia), che funge da collegamento con la più cospicua terza parte, Lampo di vita nascente, che raduna i versi scritti in quello che Agostino avrebbe chiamato «presente del futuro», ovvero l’attesa, in questa fattispecie, l’attesa della nascita della figlia, fino ai suoi primi mesi di vita. E ricollegandomi con l’inizio, questa circostanza richiama Dostoevskij, l’adolescente Dolgorukij: non esistono solo la gettatezza, l’estraneità del vivente, la necessità, c’è anche la fondatezza, in questo caso la nascita per amore, un senso e un progetto l’hanno preceduta – così come l’ispirazione, si legge nelle battute conclusive di Ninfa alla selva, nasce dal dolore, ma ci sono anche «la gioia, la paura, la passione, l’amore, la Bellezza».
Tuttavia, ogni nascita genera altra incertezza, come l’angoscia al pensiero dello sgretolamento del nucleo familiare che acutizza il senso della fugacità della nostra vita mortale senza idea di oltrevita, per quanto decisa fosse la resistenza allo stato delle cose. Ricorre, esplicita o inespressa, la domanda sulle maglie del tempo – labirinticamente – vissuto tra la nascita e la morte, e sulla via di uscita, che non sempre è in noi. E ci sentiamo vacillare, con Vailati, nella cognizione o meno del nostro universo personale consumato tra l’entrata e l’uscita («Non resterà che poco / [...] della storia / dei nostri giorni. [...] / Saranno ormai spenti / i miei convincimenti / i tuoi fraintendimenti»). Ciò sembra dar luogo a una – non disfunzionale – nostalgia del tempo presente, nel presentimento del suo passare, e che presto smetta di essere presente: sorta di rovesciamento del cogli l’attimo verso un adesso intemporale, e il cui effetto è la svalutazione della parte corrente del tempo. Rimpiangere preventivamente la nostalgia di un presente non vissuto e senza memoria, con Borges: «Sento già la nostalgia di quel momento in cui sentirò la nostalgia di questo momento», Atlante (1984); ma già in Nostalgia del presente (1981) la non convergenza tra desiderio e realtà (mancanza nella presenza), o una convergenza situata nel divergere del tempo e dello spazio, negano il presente e il futuro.
Ma amare è anche amare contro il fugit invida aetas. E la poesia che funzione avrebbe in questa contingenza? Inoltre, la ragion poetica e una vita trasfusa in fonemi possono mettersi in connessione? Può esserci complementarietà tra i due paradigmi? Poesia, con Proust, è «pour ne pas oublier», giacché: «Come bruma l’oblio scancella i volti, i gesti che furono adorati / nel divino ‘una volta’» (Poèmes, trad. it. di F. Fortini). E gli fa eco Derrida: «salvare nel ricordo quella cosa che insieme si espone alla morte e si protegge» (Che cos’è la poesia?, 1988, trad. it. di M. Ferraris). In generale, per Vailati la poesia non è sufficiente a sé se scorporata dalla vita (e Luzi: «Tu cantami qualcosa pari alla vita»). Attenendosi ai margini della vita, che è un incontro tra corpi, la poesia si allontana dalla sua genetica innaturalezza, o dal suo statutario «scarto dalla norma».
Tornando al punto. L’essere è essere geworfen cui resistere. Il lirismo di Vailati è obiettivo e ben poco concede al modulo ermetizzante e all’obscurisme di narrazioni dell’asintotico invisibile-indicibile, così come a una scoscesa modalità analogica o a uno straniamento mimetico che surclassino le forme di designazione dell’increspatura. Ed è la luce che tenta di linearizzare l’alone psicologico incluso nell’oscurità della poesia. E se c’è comunque pathos della parola, non c’è gerarchia nel materiale linguistico. Consapevole come Vailati è, credo, che il nome che vorrebbe fermare l’ineffabilità, o per manipolazione semantica nominare, con la pretesa di denominare, il baluginare del mistero, soccomba alla stessa transitorietà dei segni del suo codice quotidiano, reificato nella letteralità della parola ordinaria stretta ai rapporti affettivi che la ispirano sfuggendo la deriva retorica. E forse il nome medianico – derivante dal quasi sacro alfabeto dell’umano – potrebbe rivelarsi più labile del nome inequivoco non destituito di referenza, per il fondamentale vuoto sottostante al primo. Poesia è potenzialità espressiva senza uscite dal mondo, un processo di scrittura che ridisegna una microstoria non enfatica e quindi estranea agli idoli indolori scissi dalla vita e talora sorpresi dalla parola di tono alto che deflagra o che scolpisce o drammatizza la cosa. Vailati nega l’attribuzione del focus poetico ai non detti e agli echi e agli aneliti di infinito – e specularmente, siamo al naufragio linguistico del nome immortale. L’investimento degli strumenti formali verso l’uso linguistico della convenzione può alludere al fatto che il nome della poesia, qui esplicito e disteso, non è più, se mai lo fosse stato, lo strumento conoscitivo deputato allo scioglimento dello iato tra l’essere e il dire.
Come conciliare il diffondersi del fattore caotico del labirinto metropolitano e del Nachreden, nel suo vuoto e impersonale parafrasare il nulla, o nella superficialità della Gerede incurante del nesso originario tra linguaggio ed esistenza, con un verseggiare che rischia esiti immusicali – in quanto nominazione semantica e referenziale – mentre accampa una forte domanda di senso? Oltrepassando la prospettiva di modi linguistici dell’esprimere l’inconosciuto o la tipologia versale che vede il nome fondato su un’assenza, su un’eccedenza di vuoto, su un’ombra, su una opacità ermeneutica. Se Vailati mira all’essenzialità del verso (dove l’omissione si guarda bene dall’essere più essenziale di ciò che viene espresso), scarta tuttavia l’ipotesi di una essenzialità del materiale lirico per illuminazione o per frizione straniante, del dominio dell’analogico sul logico, il che ha come esito successivo una dilatazione del potenziale terminologico oltre il verbo dell’immaginazione, in sintonia con il rimettersi al carattere dato della nostra esistenza, a quella «morsa della realtà di tutti i giorni» di cui si parla nella quarta di copertina di Luci da Oriente.
Questa rinuncia a una tessitura verbale e a un livello intonativo che incidano le così dette cose ultime – se può esistere qualcosa di ulteriore alla vita – non attenua la vocazione alla forma e a un disegno di relazioni strutturali e prosodiche, come mostrano un po’ tutte le opere di Vailati, per via di una scaltrita, benché non scorporata, tecnica evocativa che nulla ha mai lasciato al caso. Nella versificazione debolmente – diciamo: non pervasivamente – diaristica e nell’interpretazione soggettiva del verso istituzionale risaltano l’esattezza nomenclatoria e la linearità dell’aggettivazione a discapito della sofisticazione del dettato; rileviamo una architettura lirica in rime irregolari e non strutturanti (che comunque cooperano al respiro ritmico dello strato sonoro) che si incarica di dissolvere le incrinature negli stacchi tra flusso di coscienza e dialoghi, nelle intersezioni dei piani temporali. L’uso da un lato dell’enjambement, dall’altro della rima baciata, sembra suggerire una dialettica tra prorsus e versus, tra la gettatezza del tempo proteso e il ciclico tornare del tempo su se stesso nel moto assiduo della memoria.
A questo amalgama testuale pertanto concorrono il ritmo, l’inflessione e la correlazione dei diversi strati tematici e temporali, la cui sconnessione avrebbe dato luogo a una fuga di segmenti, di luoghi, di effetti retrospettivi e di pensieri dell’io lirico, in altri termini a una diffrazione delle risonanze in costellazioni prive di nessi e di rinvii semantici, a un senza tempo nel cui ambito il ricordo non sarebbe neppure sentito come proprio. Mentre la trasparenza delle ombre dell’ora è percepita quanto più si restringe il campo degli affetti e delle cure e ci si sottrae alla psicologia collettiva, al mare dell’oggettività, alla numerosità della folla amorfa, della massa standardizzata che ha assimilato la lezione della moltitudine, come osserva Silvio Raffo in Prefazione. Così, poesia per Vailati è una presa di distanza dalla farragine verbale, dall’esasperante brusio glossolalico e ipnotico e dalla chiacchiera ideologica e mediatica, dalla fatua ed elusiva Gerede che ostruisce il pensiero rammemorante, e che scambia l’oscurità per il chiarore, e il suono insensato e il senso collassato per significati («Da ogni parte si levano le voci / ed è un tam-tam»).
A soddisfare questa tensione alla distanza come protezione è assunto il simbolismo della luce affinché nebulizzi «l’oscuro presagio di nuvole», le «sagome d’ombra» ed echi di voci già ingoiate dalla notte. Lumen, allora, che trattiene qualcosa di affine alla luce divina, se pure nella diafania di una vaga speranza. «Luce» implica anche un essere evidente, l’apparire, l’essere raggio, chiarità gettata sull’origine. Del resto, la poesia stessa è origine di luce – benché fossimo sideralmente, e radicalmente, lontani dall’estetica medioevale, dallo spirito del dantesco passaggio mistico dall’oscurità allo splendore. E dalla visione di Agostino della luce come condizione della conoscenza.
Dalla luce alle luci dell’Est garanti della continuità della vita. La luce, qui sul momento richiamata nell’esergo luziano, era un elemento centrale, come si ricava anche dalla ricorsività della parola, in Piccolo canzoniere privato (e la nascita costituisce il transito per eccellenza dal buio alla luce), di cui leggiamo l’incipit: «E se qui ancora tace la mattina / e non riporta dal passato un caro / viso morto, altre morti già saranno / come tue, tanto indefinibili», dove la luce del passato smorza l’abisso scavato da un vuoto oggettivo. Ma anche in altre opere di Vailati, là dove un’alba, seppure pallidissima, è il circolo infinito della luce che segna il riattivarsi della memoria e della vita dall’oblio – che come più volte è stato osservato, non è dimenticanza per difetto mnemonico, una anomalia del sistema memoriale, ma la sua condizione necessaria, giacché senza il temporaneo oblio di innumerevoli stati di coscienza non saremmo in condizioni di ricordare alcunché.
Nella quarta sezione, eponima, di Luci da Oriente il motivo del risveglio attraverso la sorgente luminosa si erge a qualcosa di metaindividuale, per poi tornare nella sfera dei due soggetti dialoganti: la luce di cui esistiamo sorge a Est e tutto avvolge e rischiara, come in una rinascita, con il disperdersi del crepuscolo e il diradarsi della nebbia. Dalla luce sfilacciata e versata nei riflessi di alcuni scenari liquidi del Moto perpetuo dell’acqua (2020, Introduzione di Paolo Ruffilli), la luce diviene parola chiave in Vailati, nell’accezione simbolica di uscita dall’intrasparenza verso la visibilità e una possibile ascrizione di senso, l’aurorale speranza di esprimere l’universo sommerso del nostro essere stati. È l’«albeggiare» di opere precedenti, in Sulla lemniscata – Ombra della luce (2017, Prefazione di D. Battaggia), ad esempio. Con il passare degli anni spesso la visione delle cose si fa più chiara, mentre, e forse proprio per questo, perché le identità che ci avevano ispirati, implicati, illusi sono profondamente mutate o svanite o spente, il loro senso al contrario si perde, sicché il rapporto tra l’esperienza e il suo senso è sempre inversamente proporzionale. Se la vita non va a lezione di tenebre, la luce-verità sembra tuttavia un binomio ancora incagliato nell’ombra – o in ossimoro, nell’«ombra della luce» –, quasi, come nel testo di epilogo, a fermare con altre nomenclature il dualismo perenne tra determinismo e speranza. Un’apertura «al nuovo chiaro», lievissima rispetto al nucleo emotivo categoricamente dato in incipit, ma pur sempre un’apertura.
Credo che sia una cosa troppo seria
confondere d’inverno con la nebbia
quel poco di luce che da oriente
risale nel piovigginare. È strano,
ripeto fra me – e non mi riconosco
sentirmi dire una cosa tanto uguale
a quel pensiero ormai così banale
sullo stato del tempo. Ah, non è questo!
tu esclami guardando più lontano
aprirsi verso est quella cortina
e dissiparsi dentro la mattina
la sua velatura al nuovo chiaro.
Elisabetta Brizio