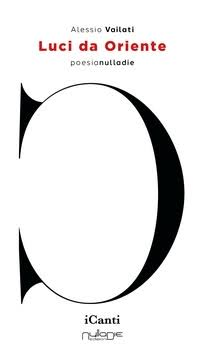Non so se mi era
mai accaduto:
la combinazione
nella continuità
l’incastro più assoluto
Affari di cuore

Prologo. «L’abito rosso pieno di lune le si gonfiava palpitandole addosso ad ogni soffio. E io parlavo per bocca di Pessoa, guardandola negli occhi, sotto un ombrello aperto per ripararci dalla polvere dell’acqua». È il passaggio ecfrastico dell’immagine di copertina (opera di Jack Vettriano) che figura in uno dei punti cruciali di Fuochi di Lisbona, ultima opera narrativa di Paolo Ruffilli (Passigli Editori 2024, con Nota di lettura di Antonio Tabucchi). Non sfugge, lungo la narrazione, la ricorsività della forma avverbiale «addosso» (sulla persona, dentro di sé, in corpo), nome chiave, come in Affari di cuore, connotatore del testo nel suo diffuso designare, nell’idea di vicinanza, un forte coinvolgimento della dimensione del corpo, anche come spia della manifestazione fisica di condizionamenti psicologici o di stress emotivi, l’addensarsi sulla pelle di ansie e di paure. La parola implica il corpo come ricettacolo delle tensioni del mondo esterno, e attraversa tutta l’opera se pure, appunto, diversamente contestualizzata nell’articolazione narrativa.
Fuochi di Lisbona è un romanzo molto lirico cadenzato in modulazioni di pensiero, denso di atmosfere, più di suggestioni e di riflessioni che di eventi, riflessioni che sconfinano nelle parti dialogiche – a giudicare dalla serietà dei ragionamenti e dei giudizi dei pochi personaggi che vi figurano. Non romanzo mimetico puro, quindi, a tratti romanzo saggistico con inserti di carattere critico che differiscono il tempo del racconto, quando nella superficie narrativa si profila una soggiacente Weltanschauung, insieme a sparse, dirette o dissimulate, dichiarazioni di poetica.
Senza nome il protagonista maschile, prima persona del racconto, narratore omodiegetico perché presente come personaggio nella storia che sta narrando, autodiegetico – il così detto «grado forte dell’omodiegetico – in quanto coinvolto nella linea del racconto come personaggio principale. L’identità dell’io narrante emerge nei discorsi con altri personaggi, quando si rivela riflettendosi nel linguaggio. «Vita» è l’emblematico nome della protagonista femminile. Relatore a un convegno (nel quale avviene l’incontro casuale e folgorante con Vita) su Fernando Pessoa, a Lisbona, il set dell’azione diegetica, il protagonista si mette sulle sue tracce, e più ci si inoltra nella trama e più le due esistenze si incorporano, la seconda divenendo esplicativa della prima, quando la prima cerca nella seconda un senso dell’arcano dell’amore, che è l’arcano stesso della vita: Vita in questa fattispecie. Il protagonista si sente erede degli enigmi di Pessoa, sente di percepirli, di condividerli, quasi fossero, Pessoa dice, una «invisibile tenace ragnatela che ci avvolge, fatta di tante congiunzioni sotterranee...». Henrique, l’amico diplomatico del protagonista, prova a relativizzare certi eccessi di lui, sia nella circostanza dell’immedesimazione con Pessoa, sia in quella del rapporto amoroso con Vita, rapporto a rischio di perdizione e dalle conseguenze imprevedibili in quanto donna lusitana.
L’alternarsi dei caratteri tondo e corsivo, del tempo della narrazione e il tempo di Pessoa, nella dimensione spaziotemporale definita dal cronotopo romanzesco, salda nel profondo le anime dei due protagonisti pur nell’espediente letterario della differenziazione, e suggerisce un io narrante simmetrico, nella prospettiva aperta di un io narrante e un io narrato. Io è il protagonista conferenziere, io è Pessoa: i due piani narrativi nel tempo misto della scrittura e della letteratura si distinguono unicamente per i caratteri tipografici con cui sono scritte le loro storie, che nel pensiero del protagonista vengono riportate ad unità senza seguire un doppio filo tematico. È la regola che presiede alla visione di Ruffilli (e che farà dire all’occultista: «lei è del gruppo dei fluidi dall’occhio sfaccettato», quindi, più persone in una).
Il tempo narrativo è successione, decorso diacronico. Ancor più in presenza di esseri del passato, che qui potrebbero dar luogo a una sospensione della linearità dello scorrimento temporale, mentre li vediamo perfettamente situati nella temporalità della trama, malgrado la specularità dei contesti e il gioco dei rimandi nella costruzione testuale: protagonista-Pessoa, Vita-Ophélia (entrambe le donne sono di dodici anni più giovani degli uomini). L’alternanza, nello stacco tra tondo e corsivo, di presente e di passato, di vite reali e di vite letterarie comunque non finzionali (esistite anche fuori dello spazio narrativo), promuove questa coesistenza anziché marcare uno scarto temporale. Ma il sovrapporsi di realtà e di finzione – meglio, di eventi e temporalità asincroni, anche nel quadro di un Pessoa ortonimo –, se poi si aggiungono le traduzioni di Ruffilli delle parti corsivizzate, delle lettere e dei diari (nonché dei testi di Amália Rodrigues e di Herberto Hélder), sembra incrementare i livelli di lettura. Che la lettura sarà stratificata è quanto meno evidente. Leggevo che già solo le Lettere alla fidanzata costituiscono un doppio della realtà (un conto è l’amore, un altro le lettere d’amore), il che basterebbe per istituire un gioco di specchi, uno specchiarsi nella propria riflessione. Tuttavia, credo, lungi dal dar vita a vie di fuga, le superfici riflettenti in quest’opera non duplicano, non diffrangono, non disorientano verso altri domini con rifrazioni di controfigure astratte. Viceversa riorientano gli elementi speculari e simmetrici facendoli convergere in un unico punto (contraddizione come misura dell’unità, «la combinazione / nella continuità / l’incastro più assoluto», inerisca al Pessoa innamorato o al nostro personaggio), da far pensare che la specularità e il fattore del doppio non siano qui questioni dirimenti. Pessoa e Ophélia incrementano la trama e anticipano un destino, e anche in questo contesto l’intento di Ruffilli sembra essere la dimostrazione, lo vedremo, dell’incontro mente-corpo-ambiente con la corrente della vita nella sua totalità.
Eu sou o outro. La vita si fonde con la letteratura anche nella circostanza della relazione per il convegno (cioè l’occasione narrativa), redatta sotto forma di racconto. L’impressione del protagonista è «di entrare nella vita che è di un altro o che si infili un altro nella mia. Pessoa è quest’altro». Sembrerebbero entrare in gioco le figure freudiane e dostoevskijane del doppio, del sosia, che in Pirandello ricorrevano ossessivamente sotto i simboli dell’ombra e dello specchio quali referenti incorporei della maschera, di una autoriflessione critica dissolvente le identità individuali dei personaggi. Eppure, proprio nell’ottica della alterità, del non identico, potrebbe cadere la centralità del tema del doppio, dell’ombra di Pessoa come totalmente altro da sé, giacché l’esplorazione del doppio, per il protagonista, sarà piuttosto una esplorazione di sé (il doppio evidenziando una incrinatura del principio di identità), della propria anima inconciliata, dello scioglimento di qualità dell’uno che difettano all’altro: distinti e uniti in questa interlocuzione sul sé in quanto altro. Il riconoscimento dell’altro, di cui il doppio è il medium, può condurre a un nuovo livello di consapevolezza e di esistenza. Ancora, alle forme duplicanti e duali Ruffilli, in qualsiasi codice si esprima, antepone il soggiacente regime dell’unità dinamica, e quella ambita sfericità del soggetto che comunque urta con la pessoana pluralità degli io.
E per il momento sorvoliamo la questione dell’alterità dell’io in Pessoa (così distante dal rimbaudiano «Je est un autre», che potrebbe anche alludere ad una sublimazione dell’individualità – «semper alius et idem» – nella superiore sfera degli archetipi; e forse più affine al Campana dei Canti Orfici, dove parlava del sé trascorso come di «colui che io ero stato», e ne parlava, appunto, in terza persona), che in Ruffilli tornerà sotterraneamente e per altre vie: «l’io è un vapore che sfugge non appena ci si impegna a contenerlo», quindi rientra nella categoria del mistero. L’alterità di Pessoa («pessoa», che in portoghese è «persona», quindi, se ci rimettiamo al latino, «maschera, personaggio», tuttavia nome solo all’apparenza predestinante nella prospettiva drammatica giocata tra ortonimo ed eteronimo) ha a che fare con il viaggiare senza partire, con l’eteronimia (sintomo profondo di isteria, come Pessoa stesso dichiarava, alter ego, finzione, coesistenza di più voci nel medesimo corpo, identità in crisi e pertanto da invenire), soprattutto con il soggetto dell’esperienza così come figura nelle celebri pagine del Libro dell’inquietudine. Faceva egli dire a Bernardo Soares: «Vivere è essere un altro. Neppure sentire è possibile se si sente oggi come si è sentito ieri: sentire oggi come si è sentito ieri non è sentire, è ricordare oggi quello che si è sentito ieri, è essere oggi il cadavere vivo di ciò che ieri è stata la vita perduta».
Riscriversi. In Fuochi di Lisbona ricorre il sintagma «un’altra vita» (già titolo di una serie di racconti di Ruffilli sull’amore adulto): forse nello spirito del cambiamento e della variazione sul tema (anch’esso un titolo ruffilliano che può rimandare alla variazione nella ripetizione), le opere di Ruffilli si danno sempre tutte insieme, quasi a correlare sensi già comparsi con altri nessi ed elementi di novità da definire. Oltre le autocitazioni da Diario di Normandia, La gioia e il lutto e Affari di cuore, ad esempio, aspetti nodali della poetica e della poesia di Ruffilli, almeno da Diario a Le cose del mondo, sono trasfusi nella linea diegetica incrementandone la vitalità. Perché riscriversi è essere, esserci, essere vivi, assegnare un altro inizio al già stato. Un nuovo inizio insieme a un nuovo sguardo, un rimettere in moto il tempo come dopo una sosta.
Riscriversi allontana l’alea della stasi e come mimesi del dinamismo temporale dell’esistente nel suo divenire altro incorpora i segni di una antecedenza: ritestualizzando, tornano trame non definitivamente smarrite per avere inciso indelebilmente in una maniera di essere. E il dinamismo è il tratto essenziale di una poetica fondata sulla metamorfosi, ovvero «la regola del mondo», che in poesia dava luogo a nuove attinenze e a fulminee disgiunzioni: «È proprio andando che si capisce / qual è il rovesciamento di ogni prospettiva» (Le cose del mondo). Ed è ciò che dà la misura della inesaustività della ricerca di Ruffilli, come egli rende, nei versi e nella prosa, attraverso quella tempestiva conclusività nell’atto di compiersi sulla pagina, conclusività che se restituisce l’impressione di un sistema definitorio, in effetti non fa che rilanciare, dilatandola, la complessità di un enunciato in sospeso per quanto teso alla sintesi.
In viaggio. Nel dire «andando» è esplicito il richiamo al viaggio (in treno nell’opera in versi, in nave come l’Ippolito dell’Isola e il sogno, in aereo come il protagonista di Fuochi di Lisbona), tema che ispira la sezione liminare delle Cose del mondo. «Mistero di ogni partenza e di ogni arrivo», il bisogno e il timore di allontanarsi. Perché il viaggiatore delle Cose del mondo era sintonizzato sul ritorno prima ancora di partire? Forse perché il viaggio implica un raffronto istintivo con il noi di altri tempi nello stesso luogo, e il riscontro non può che essere in perdita. O perché insinua il fattore della casualità, l’inaspettato, l’incertezza di incorrere in qualcosa che potrebbe scombinarci la vita, come accadrà al protagonista di Fuochi di Lisbona. Oppure, nelle forme di Baudelaire, per resistere alla seduzione dell’ultimo viaggio: «Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, / Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu’importe? / Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!» (Le voyage).
I viaggiatori ruffilliani valorizzano gli intervalli, il soffermarsi lento che dissolve le ovvietà presunte, il perder tempo per trovare qualcos’altro. Non la conquista di un approdo quindi, ma la ricognizione della propria identità è il vero movente del viaggio, tra il partire e il tornare («Di corsa, inseguendo se stessi, / la propria figura smarrita») con il riconoscimento delle proprie spoglie e delle occasioni mancate («in questo / spreco di sé nel mondo fuggendo, intanto mutando in gara infinita / – intravista e perduta – la vita», ovvero anche Vita), tuttavia mai nell’ottica classica e fosca di una catabasi.
Nello svolgimento narrativo il viaggio è per il protagonista una destabilizzazione dell’immobilità, lo «sforzo per decifrare gli enigmi del mio stare al mondo», verificare il proprio centro, una decostruzione del soggetto intrapresa per mettere alla prova la sua labilità, o per sorprendere una verità che era solo latente. È partire con «una valigia piena d’ombre», e tornare forse con una ombra in più. Del resto, dice Hélder, «la nostra vita è incomprensibile proprio come l’aldilà».
L’occasione del viaggio è il desiderio di scandagliare l’amore di Fernando per Ophélia Queiroz, di colpo spezzato. «Perché – è Pessoa a dirlo –, amandoti, ho fatto con te l’esperienza della improvvisa dismisura. La scoperta che la fame non può essere saziata e tutto resta aperto e senza fine». Viaggiare è «dare orizzonti mobili alla mente», è – Pessoa dice – «essere altro costantemente. Neppure più a se stessi appartenere. Già nell’assenza dell’avere un fine e senza l’ansia mai dell’ottenerlo». Gli fa eco Ruffilli: «scorrere appunto dentro se stessi e dentro il mondo, senza fermarsi. Perché il ristagno è il principio del morire».
Mutatas dicere formas. È acclarato: la forma narrativa di Ruffilli è intrisa di pensiero con frequenti balzi in ambito extradiegetico, e, nei casi in cui è questione dell’ordine delle cose, extraletterario. Si tratta qui di descrivere le forme mutate, meglio, in perenne movimento. Come esemplarmente in Natura morta, anche in Fuochi di Lisbona la metamorfosi, la mutazione di forma che comporta una mutazione di essenza pur nell’inclusione, costituisce il nucleo generatore della vita. Forma che si trascende da un lato, concrezione delle cose dall’altro. Status di continuo mutevole, «risorsa dell’incrocio, forza insuperabile dell’ibrido dentro il fluire della vita». Passaggio dinamico tra forma e flusso, la metamorfosi comporta un cambiamento con implicazioni del nuovo, di un fattore di crescita, e forse anche di un salto qualitativo, comunque ekstatico: l’essere in atto delle cose, fuori dal permanere e quindi oltre la stagnazione della condizione tautologica (in merito rimando al mio Moving life. Avvicinamento a Natura morta di Paolo Ruffilli, Fermo 2019). «Nel paradosso dei contrari sta la vera legge della vita. Si entra uscendo e il vero ingresso, sì, sta nell’uscita».
Nesso della contraddizione. È il fondamento ontologico della poetica di Ruffilli. Luogo di reciproco trapasso degli opposti, che trattiene il contrasto mettendolo in tensione nella coesistenza degli elementi, la compresenza dei poli ossimorici è un fattore onnipervasivo («Nulla è, tutto coesiste», Pessoa diceva). Ogni aspetto dell’essere sorge da una combinazione, dall’interazione dinamica tra poli antitetici, per cui il principio di non contraddizione e del terzo escluso hanno per Ruffilli una consistenza puramente illusoria. Esiste invece un tertium datur, una terza ipotesi che la logica esclude, che potremmo piuttosto definire una relazione di opposizione, un mutuo assimilarsi dei contrari. È la coerenza della trasformazione, per cui qualcosa può, insieme, essere e non essere, immesso com’è nella metamorfosi che degli opposti mantiene la radice comune. L’immoto è il regno della tautologia, dell’identità di ogni cosa a sé stessa. Nella relazione enantiologica, di compresenza paritaria e sinergica degli elementi di opposizione, per cui il mondo dell’esperienza fa il proprio corso per coppie contrastanti ma interconnesse (moto-stasi, vuoto-pieno, alto-profondo, vita-morte, luce-buio, gioia-lutto, libertà-imprigionamento...), la conciliazione dei contrari va cercata nell’essere l’uno condizione di possibilità dell’altro.
Secondo Ruffilli al calco irrigidito «la natura preferisce la mescolanza, l’ibrido, il composito, la trasgressione. Gli uomini sono invece ossessionati dall’omogeneo, dalla regolarità». Il mistero del mondo sta in ciò che si vede e che bisogna attraversare con il paradigma immaginativo – il primo principio, ma che riguarda gli umani, nel senso che siamo noi a doverci impegnare a varcare l’evidenza, mentre lo stato delle cose resta tale con o senza di noi – che si porta dentro l’immagine a sondare la realtà, diceva Ruffilli, «del retroscena» della statica logica dell’essere.
Tornando al punto della contraddizione, della realtà incoerente. Amor et mutatio rerum: la contiguità dei termini della opposizione viene in Fuochi di Lisbona enfatizzata dall’amore al femminile che dà felicità e dolore, la forma alterna dell’amore. L’amore è «l’incastro più assoluto», si leggeva in Affari di cuore, e una terminologia che designi la piena coincidenza degli opposti torna nel romanzo (coppie della discordia concors amoris: «inchiodata-sfuggente», «contenta-inquieta», «salvato-perduto», e l’esemplificazione potrebbe continuare), in cui si disseminano ossimori il cui stridore dialettico traduce, appunto, il carattere promiscuo della realtà. È la pluralità dell’essere ricondotto alla relazionalità ossimorica della varia unitas: «Essendo tutto mobile tutto resta aperto. Essendo tutto cifrato, tutto resta avvolto nel mistero». Molte le antitesi di ciò che trasmuta e che quindi vive morendo e viceversa, ma molte anche le sfumature, le tonalità di transizione (come la sinfonia dei verdi che trascolora sull’acqua: «smeraldo, mela, bottiglia, petrolio, oliva, Sèvres») in cui le antitesi si travestono nelle gradazioni della sera, nei toni della notte, nei colori del buio: «beige e sabbia, ormai, il cielo e il fiume. Ocra, terra di Siena, ruggine, cacao, avana, prugna: le case e la città erano prese in una gamma mescolata di marroni nella polvere d’oro della sera che moriva». E ancora: «Nel bianco si scioglievano i colori. E il bianco, mi diceva Henrique, era la vera tinta di Lisbona. Un bianco impolverato che rifletteva l’ocra, il rosa lento dell’aurora, l’oro meridiano, e poi di seguito il crema, l’aranciato, fino al violetto, al lilla, al blu oltremare».
Convergenza degli elementi primordiali. Risaliamo brevemente alle affinità e alle dissomiglianze tra Fuochi di Lisbona e L’isola e il sogno: il giovane Nievo esordisce nell’elemento acqua che gli rende la sostanza di un paesaggio sentito, quasi fisico, simile a un essere vivente. Il protagonista di Fuochi di Lisbona si presenta sotto il segno dell’aria, della leggerezza. Ippolito naufraga metaforicamente prima (in seguito all’aver sperimentato l’amore assoluto ma infattibile con l’inafferabile e magnetica Palmira) e letteralmente poi, il protagonista di Fuochi – di età più matura rispetto a Ippolito – a partire dalla scoperta della prossimità dell’amore con la mancanza, a sua volta generata dall’amore della pienezza, elabora un’altra visione della vita. Come accadeva a Ippolito, appoggiato alla balaustra della nave in un interludio dove le tonalità del paesaggio e il trascorrere sull’elemento liquido promuovevano una risemantizzazione retrospettiva, anche qui, ma nel viaggio di ritorno, e soprattutto con spirito diverso, hanno luogo lo stream nello specchio di acque e la semantizzazione dei suoi riverberi. Il protagonista di Fuochi: «Immobile sul parapetto. Di fronte all’acqua dai riflessi pieni di ombre, di fronte al cielo sconfinato sopra di me e a quelle rive che sembravano parlare d’altro». Parlando in figura, il fiume in piena infine si placa nello spazio della foce.
È un’alba che fa da crinale. L’amore lo aveva travolto, ma «l’istinto spingeva ormai verso la luce di un’altra mia stagione». Il protagonista si ritrova proprio quando «ormai era perduto». E ciò potrebbe valere in generale in relazione al modus poetandi di Ruffilli: il secondo nome, «perduto», sembra trattenere in sé, nell’opposizione, un nesso con il primo, «ritrovato», che lo prefigura stabilendo un vincolo necessario tra i due termini. È lo stilema ruffilliano che sancisce l’unità del disuguale, l’origine condivisa di una apparente discordanza in un dettato deautomatizzato, progressivo-regressivo, fattivamente incongruente, a stilare la continuità, la diacronia nella simultaneità.
«Il dolore mi stava facendo percepire le cose con vivezza nuova. Sentivo di appartenere ancor di più alla vita», d’accordo con Pessoa e Hélder circa i pensieri negativi sull’inutilità del mondo «che facevano ammalare le persone e fermavano il motore della vita». Quanto al soggetto innamorato e deluso, si accorge che questo amore è meglio averlo perso dal non averlo mai conosciuto. In fondo – con Pessoa – «niente dura, mai, per sempre. E niente, per sempre, mai, finisce».
Lungo la narrazione gli archetipi cosmologici incarnano un ruolo o rivolgono dei segnali ai personaggi, e in Ruffilli rimandano esclusivamente a una dimensione vitale. Il protagonista fa il suo esordio nel regno delle nuvole e dell’aria (Nuvole, già titolo di un’opera in versi di Ruffilli con immagini di Fulvio Roiter), quindi nella leggerezza, nella levità (per alcuni versi simile al galleggiamento di Ippolito sulla nave verso l’isola). In questo inizio il medium è il cielo. Lo stesso che nelle ultime pagine favorirà un trascinamento di pensieri pervenuti a un nuovo stadio di consapevolezza, fluttuando nel processo resiliente senza giungere a una conclusione definita, «come la coscienza intermittente della vita».
L’ampia foce del Tago vede la cessazione del fluire, dell’acqua in movimento e la morte ad Occidente dell’Europa. C’è l’idea della foce con le sue acque di transizione – di nuovo, mescolanza e unione del diverso –, l’indistinzione di un continuo finire che non è finire, quando, nell’inerzia delle acque della foce, senza scalfiture di corrente o increspature di onde, il fiume cessa di essere fiume e il mare non può ancora chiamarsi mare per via di quella «linea invisibile che separa il fiume dall’oceano mare». Lisbona non si limita a fare da sfondo o da struttura topologica che emette una proliferazione di significati. Città «anfibia», è situata tra una terra che diviene fuoco e il dominio dell’acqua, nel gioco dei riflessi, nell’«impero della luce che è rifratta». La sua luce è uno «specchio ustorio» sconfinato che satura ogni vuoto, ogni mancanza, ogni fenditura. Versicolori fasci di luce che si intrecciano in un prisma prezioso, scomponendosi e facendo risaltare per risonanza e riverbero i loro «reflets réciproques», avrebbe detto Mallarmé.
In «Le navi del Tago», penultimo capitolo, così come nell’Isola e il sogno, l’elemento liquido innesca il pensiero e la riflessione sul senso o nonsenso del tutto. Ruolo qui assolto dal fiume con i suoi colori nella rinascita del giorno. Guardare il Tago «fino a scordarsi di guardare», «sentire intanto l’universo, annegarci dentro». E Pessoa: «E provare che tutto aveva anche un altro senso, anche l’avere un senso». Guardare gli effetti cangianti dell’acqua, il suo scintillio, gli effetti luministici sulla superficie liquida, come una tela dalle tinte incompiute, dalle sensuali dissolvenze cromatiche: è la stessa ed è altra, si trasforma restando lì presente. «Non ci si poteva opporre allo scorrere dell’acqua», cioè della vita (quindi non si poteva resistere a Vita), che «pretendeva che si prendesse parte». Il fiume si versava nel mare (ontologia della foce, come raffigurazione di un passaggio temporale e del gettarsi, e perdersi, in un altro corpo), il passato e la forma alterna dell’amore galleggiavano con la corrente. L’amore – la gioia – è contiguo al dolore, al lutto (nella nota diade ruffilliana), così come il nuovo e l’anteriore sono incorporati. L’acqua ha a che fare con il tempo ma anche con l’amore, con la secrezione, con «l’antro muschioso», umido, oscuro.
All’elemento fuoco si rifà il titolo dell’opera, esplicato molto in là nel racconto: «Dalla finestra, il Tago era un magma incandescente e a ondate si espandeva nella stanza. Batteva il suo duro suono dentro la fusione del metallo. Pulsava e ribolliva nel tramonto. I fuochi di Lisbona. Le tende, le pareti, i cuscini, le lenzuola, i corpi di noi due amanti... Carminio, scarlatto, vermiglio, porpora, amaranto. Non era il rosso la tinta dell’amore?». È la passione amorosa associata ai riverberi lussureggianti del tramonto, fin dalle prime pagine dell’opera il fuoco è passione nell’ora del «rosso sangue e oro che l’occhio non riusciva a sostenere», e che somigliava alla insostenibile pienezza della passione d’amore, la «dismisura» di cui parlava Pessoa. E la stanza dell’amore al tramonto era invasa da un sole che «divampava sulle case facendone un vasto specchio ustorio». Le lacerazioni che scandiscono la nostra esistenza altro non sono che «il segno della luce, non del buio», benché le lezioni della vita, il sentimento di distruzione che ha facoltà risanatrici, vengano assimilati quando sono ormai inutilizzabili.
«La terra è fatta di cielo», si legge nei versi di un Pessoa ortonimo. Che nelle righe corsivizzate del romanzo parla di unità degli elementi primordiali: «ciò che scorre deve per forza, intanto, consolidarsi. Essere fuoco, e, insieme, terra». Così per Ruffilli, per il quale, come ben sappiamo, all’orizzonte della discordanza c’è sempre un’origine comune. Come la Bocca dell’Inferno è simile all’amore, anfratto desiderabile e travolgente «per quel suo gorgo vorticoso che mescolava gli elementi e cancellava i confini tra terra, acqua e cielo», il «cielo del mistero» di Nuvole. E Lisbona è «un mucchio di braci ardenti nel nero mescolato di terra e cielo».
E accennando ai pendolari, nell’intreccio delle voci del protagonista e di Pessoa: «Era mare la loro stessa terra: Voce di terra che anela al mare». C’è coincidenza e non, come in Proust, inversione degli elementi. Ma le divergenze non sono poi così nette: se in Proust, specie per mano di Elstir, abbiamo una alchimia della materia, e a livello di testo, un passaggio ecfrastico in parole altre, la metamorfosi in Ruffilli è congiunzione degli elementi in forza del loro stesso trasmutare. Entrambi in fondo decostruiscono la realtà nel mutuo condizionamento degli elementi, nel trapasso o nella emulsione di aspetti eterogenei della realtà esterna. Perché nulla è prigioniero di una convenzione. Il principio di Rufilli è di non demarcazione, e a questo punto del libro ne è l’emblema la foce del Tago.
Il protagonista deve la scoperta della vera Lisbona al suo amico Henrique: terra satura di luci, aromi, colori, sfumature, terra incantata che fa innamorare e solleva i dubbi degli amanti e gli enigmi dell’esistenza. Lisbona è soprattutto terra terminale, ai bordi del mondo, città «dal corpo femminile», tentacolare per la sua forza di attrazione, «terrazzo sull’orlo dell’abisso: un bastione per la vita, a reggerla e a salvarla dal vuoto con il quale confinava». «Diga – Tabucchi ribadiva nella Nota – costruita nel tempo a reggere la deiezione a occidente dell’Europa verso l’Atlantico e l’ignoto». Quindi, una terra tra splendore e nihilitas, anch’essa in equilibrio ossimorico, dove il contrasto sembra postillare l’interagenza delle differenze delle differenze. È terra come la vita che pretende di essere vissuta qui, ora e fino alla fine, «anche se non serve a niente. Anche se il tempo sempre cancella tutto con il suo passo indifferente», e siamo all’explicit. «Lisboa», «nome d’incanto» (Battiato), che fin dal suono della sua lingua trasmette lo spessore dell’eros. Lisbona, città donna oltre la quale è voragine verso il fondo dell’ultimo orizzonte, come nell’amore per via del «salto nel vuoto che esso pretende».
Amare. È un fatto, l’amore si fa (già in Affari di cuore). Vita ripeteva al protagonista che bisognava concentrarsi su quel fatto evitando di fantasticarvi. È un fatto che implica l’assorbimento dell’amato/a. Che provoca la nostalgia del presente, «nostalgia di quello che, pur nel possederlo, sentivo comunque inaccessibile avendolo raggiunto», qualcosa di più di una nostalgia della pienezza del presente, cioè della percezione del suo inesorabile passare. È il tipicamente ruffilliano sfuggire della cosa non appena si crede di averla conseguita. Pessoa, pensando a Ophélia: «più e più si fa l’amore e più si resta invece disperati. Perché si fa esperienza di una felicità talmente grande eppure così breve, che si scatena poi la sofferenza del desiderio, di nuovo in astinenza». Tuttavia, altrove: «Non l’amore, ma i suoi dintorni valgono la pena... La sublimazione dell’amore illumina i suoi fenomeni con maggiore chiarezza della stessa esperienza. [...]. Possedere significa essere posseduto e dunque perdersi. Soltanto l’idea raggiunge, senza sciuparsi, la conoscenza della realtà». Viceversa, per Ruffilli dai contrari sorge l’unità dell’amore. In Fuochi di Lisbona l’amato/a gode dell’essere possedente e insieme posseduto, compreso e compenetrato in sé stesso, due in uno e uno in due. Carnale e universale, femminile e maschile, esperienziale e sublimato in parola, nodo inscindibile di yin e di yang, di spinte opposte e complementari, come nel pensiero orientale. Se per Lucrezio gli amanti cercano invano di congiungersi e nella impossibilità del pieno appagamento sta il loro tormento, qui si verifica piuttosto il tormento della gioia, lo svuotamento nella e della pienezza. E molto orientale è questo sguardo che gode del mondo, del corpo, dell’altro da sé nel momento stesso in cui ne percepisce la caducità e l’impermanenza.
La dicotomia tra eros come affare di testa o affare di cuore finisce per sciogliersi: come in Affari di cuore, l’eros dal cuore sale alla testa nel delirio sentimentale che progredisce – o regredisce – in ossessione mentale segnando i vari stadi del discorso amoroso. Il desiderio raggiunge una maggiore intensità nell’assenza. Ma assenza è il calco, il vuoto come presupposto del pieno, per questo Ruffilli parla del «richiamo dell’assenza», del «risucchio del vuoto». Amore è un viaggio al termine del giorno, verso il sole che incendia il paesaggio, e che procura un senso di irretimento, di malattia, in quanto «sogno dell’unione più totale», l’aspirazione degli amanti di penetrare i segreti degli amati.
Essendo il corpo voluttà e malattia, nonché sede della morte, c’è un legame fisiologico, e non solo emotivo, nelle cose dell’amore, sicché Ruffilli in alcuni punti sembra interpretare il ruolo del dottor Behrens, che nello Zauberberg, coerentemente con la propria ideologia medica e chimica, tutto riconduceva alla dimensione organica. Un dottor Behrens ribaltato, le cui diagnosi ineriscono alla vita, alla esaltazione del corpo e non alla sua corruzione: «è l’eccitamento che accelera di colpo la circolazione, rende lo sguardo sfavillante, fa aumentare il colorito al viso. E il cervello, così sollecitato dall’afflusso di altro sangue, è stimolato dalla mente».
Il primo sintomo della saudade, quel sentire malinconico che si caratterizza per la sua indefinibilità, quell’intrico di nostalgia, di rimpianto e di desiderio struggenti per ciò che non si potrà mai possedere che prende a Lisbona, è «uno stato di euforia, come allo scoppio di una febbre». Poi la sintomatologia dell’amore, a livello fisiologico, una «attività nell’area cerebrale del nucleo ventrale segmentale: surplus di dopamina. Scossa voltaica lungo il plesso cervicale, brachiale, spinale, lombosacrale»; «saliva che si univa alla saliva. Quanta ne riversavano i condotti delle guance e del palato: zuccheri, muco, siero, cellule vive e cellule morte. [...]. Se era col pH la soluzione elettrochimica di tutto, che fosse pure. Combinazione più riuscita non si poteva immaginare». E le conseguenze, quelle organiche, dell’amore: «bruciore, arrossamento, flogosi, eritema, vaginite».
Tradire. Portarsi oltre gli schemi costituiti per «consegnarsi interi alla propria libertà», «violare il vincolo per affrancarsi». E Hélder: «la salvezza non consiste affatto nella fedeltà alle forme [...], quanto piuttosto nel sapersene appunto liberare». In fondo, tradirle (assonante con «tradurle», condurle al di là, quindi portarsene fuori). Il discorso esorbita dalla infedeltà amorosa che non è scontato che si consumi solo con l’atto sessuale. Tràdere è consegnare, come consegnato, tradito da Giuda. Al contrario, nella Gloria di Giuseppe Berto, ad esempio, il gesto di Giuda non è un tradimento ma un gesto d’amore che consente il realizzarsi del disegno divino, del destino del figlio di Dio. Senza il tradimento di Giuda non ci sarebbe stata la crocifissione quale antefatto della gloria di Dio.
«Tradire» non vuol sempre dire tenere l’altro al di fuori della verità. È inoltre una maniera di acquisire la consapevolezza della difficile responsabilità di fronte a libertà che possono anche degradarsi in infelicità o in sofferenza. Come in Madame Bovary e Anna Karenina, che attraverso il tradimento d’amore cercavano, con gli esiti che sappiamo, la loro realizzazione senza piegarsi a condizioni e a convenzioni. E per l’amante di Fuochi di Lisbona, la risposta alla domanda su chi siamo, se siamo attori di parti già scritte, o copie di copie, è che il vero segreto della vita è «essere copia e, insieme, libero arbitrio. Ritrovarsi in una parte obbligata e trasgredirla».
Mistero. «Indizi vaghi e tracce che si perdono nel punto stesso in cui stanno lì lì per affiorare». È «la verità / che si apre / e si richiude sull’ignoto» (La gioia e il lutto). Mistero è la vita che risorge dal vuoto, è vacuità da colmare, oscurità da illuminare. È mistero della trasformazione, per cui l’umano è parte di ciò che è accaduto nella storia. L’ambiguità è la forza e il principio della vita, il suo paradossale affidamento. Quanto più si trova e si cerca di dargli un senso, tanto più dilagano le tenebre e l’incertezza comporta l’ampliamento di una inchiesta che dura infinita.
Il mistero scolorisce nelle false sembianze insite nell’evidenza, le cui verità sono solo ombre, «tutto il mondo visibile è spettro e simbolo, la vita che conosciamo tramite i sensi è un’illusione. L’iniziazione è il graduale dissolversi dell’illusione. E la ragione per cui non c’è significato che non sia simbolico risiede proprio nel fatto che l’iniziazione non è pura conoscenza, ma è anche vita. E uno deve perciò da sé scoprire quel che i simboli gli mostrano, perché così vivrà la loro vita senza limitarsi ad imparare le parole con cui ci sono rivelati» (assunto metanarrativo, che rimanda a una tesi sviluppata in Appunti per una ipotesi di poetica, a conclusione di Natura morta). Tutto passa e si trasforma e resta il mistero, incarnato qui in una serie di ossimori («realtà è apparenza», «vivente morte», «tenebra visibile», e anche questo sarebbe un elenco infinito). Mistero che balena («La schiuma che metteva in ombra di continuo il suo biancore luccicante e già ricompariva nel momento in cui spariva») solo per via di immaginazione, niente di più estraneo alla fantasticheria e alla immaginosità gratuite e svincolate, alla creazione mentale interiore.
E venendo infine al paradigma dell’immaginazione, Ruffilli, com’è noto, si situa nell’asse Leopardi-Pessoa-Einstein. Si allinea al fingersi di Leopardi, dove l’immaginazione arriva a dare forma, e nella finitezza si ha accesso all’infinito. Al fingitore Pessoa, la cui finzione è, per così dire, attiva, fattiva – oltre lo standard della finzione letteraria dell’istituzione di doppi fittizi – in quanto tramite la costruzione eteronimica crea un regno della finzione all’interno del mondo reale e storico, mentre tenta il conseguimento dell’autenticità del sentire poetico. Quindi il detto celebre «O poeta è um fingidor» non allude a una simulazione o a un mascheramento. Come scrive in Pagine di estetica, «certi stati d’animo, pensati e non sentiti, sentiti immaginativamente e così vissuti, tenderanno a definire per lui [il poeta] una persona fittizia che li senta sinceramente». E con Einstein, per il quale «l’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata. L’immaginazione circonda il mondo». E ancora: «la logica ti porterà da A a B, l’immaginazione ti porterà ovunque». L’immaginazione darà il senso «del noto sconosciuto» perché travalica il diaframma edificato dall’evidenza (si veda, in proposito, Pentacordo per Paolo Ruffilli, a cura di E. Brizio e M. Veronesi, Imola 2012).
Un punto nel Libro dell’inquietudine, che fonde il modello dell’immaginazione con il tema del viaggio: «È in noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò se li immagino li creo, se li creo esistono, se esistono li vedo come vedo gli altri [...]. La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo».
Riassunzione in uno. Gli elementi primordiali risospingono il lettore nell’anarchia primaria, origine tuttavia del tempo e della vita: la possibile radice di «Chaos», «ka», sembra evocare l’idea di cavità, vuoto, voragine, ma anche di primigenia massa informe che cela dentro di sé, in germe, tutte le forme. Così, per Ruffilli, anche i generi letterari possono essere mescidati, come riflesso della disuguale armonia che regola il mondo. E contestuali, una ibridazione e incessante contaminazione dei moduli formali verso l’assorbimento della discontinuità: l’identità di un genere partecipa dell’altro senza discrimine dal profilo dell’essenza, e ogni sua opera, lungi dall’essere un sistema chiuso, è la mise en texte della metamorfosi come motore del mondo reificata nella sintesi delle diverse arti. Insomma, non siamo di fronte a un ludus ma a un’apertura al mistero e all’oscuro balenare dell’alterità.
Anche il genere è l’ambito della trasformazione e della mutevolezza rispetto alla purezza del canone (indugio nell’immobile) e dei caratteri normativo e prescrittivo della visione tradizionale (dogmatica, inibente la libertà). Ne è prova lo stile denso di questo romanzo difficilmente rubricabile, fatto di poesia (ritmicità della prosa, ritmo dei giochi d’eco e dei richiami del mistero sfuggente), di pittura (frequenti trascolorazioni, toni improntati alla sintonia tra materia pittorica e materia musicale, giacché la musica è il moto che scorre) in un sotteso registro musicale. «Trasferisco le tonalità della poesia nelle modalità della narrativa. Anche raccontando, nella misura breve o lunga, per me trainante è la musica. Mi lascio trascinare dal ritmo. La mia prosa è poesia», Ruffilli dichiarava in una intervista.
Della componente musicale si fa espressamente carico la voce di Amália Rodrigues, la «regina del fado» – fatum – e della struggente nostalgia, che con saudade interpreta il dolore intrinseco all’amore («Amor ciúme / Cinzas e lume / Dor e pecado / Tudo isto existe / Tudo isto é triste / Tudo isto é fado»). Fuochi di Lisbona è redatto in una prosa ritmica con rime inattese e ovviamente irregolari e parole assonanti, che rendono una intrinseca musicalità della scrittura, corrispettivo in prosa dell’inflessione versale. Benché in un genere codificato come «romanzo», strati della prosa di Ruffilli richiamano certa sua versificazione quasi dell’Ungaretti «uomo di pena», che si unisce a tratti, e paradossalmente – per fondere due referenti culturali spesso addotti a proposito dell’autore –, con una cantabilità quasi settecentesca, quasi chiabreresca e arcadica, ariosa, dalla parvenza svagata e dall’eleganza severa, quasi esistenzialisticamente, assurdamente mondana. Qui la prosa rimata e assonanzata è spesso interrotta da quell’epilogarsi fulmineo caratteristico del verso ruffilliano, che ha un po’ dell’aforistico, come a racchiudere il senso di una – imprendibile – verità sul mondo.
Quanto alla contaminazione con altri generi e canoni in Ruffilli, ne parla Tabucchi (con un richiamo a Luigi Baldacci che, a proposito di Ruffilli, discettava di scrittura lieve, le cui parole sembrano note in una partitura musicale) nella Nota di lettura datata 2012, quando Fuochi di Lisbona sembrava fosse sul punto di essere inviato all’editore. Ruffilli, tuttavia, si prese altri dodici anni di tempo per raccontare il suo sogno di Lisbona di vent’anni prima.
Elisabetta Brizio